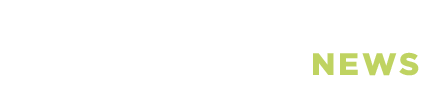Il 5 febbraio 2025 è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1372 “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”, di iniziativa della Lega.
Il ddl si pone l’obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze nell’ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall’altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese.
Le osservazioni dell'ANCE
“Il Ddl affronta per la prima volta e in modo organico il tema delle procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, da sempre uno dei principali 'colli di bottiglia' dell’attività amministrativa che sta rallentando e, in alcuni casi, addirittura bloccando le procedure di trasformazione della città e del territorio richieste sia dalla parte pubblica sia da quella privata”, ha affermato il vicepresidente dell’Ance, Stefano Betti, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Ambiente e Cultura del Senato (in allegato la Memoria).
Un passo nella giusta direzione perché nonostante i diversi interventi normativi che hanno interessato queste procedure, dal rilascio dell’autorizzazione ordinaria (D.lgs. 42/2004) a quello dell’autorizzazione semplificata (Dpr 31/2017), continuano a registrarsi rallentamenti, se non addirittura blocchi, per molte procedure edilizie private relative ai tanti immobili soggetti a vincolo paesaggistico o ubicati in aree vincolate.
Le principali criticità risiedono, però, nella natura stessa della procedura, che implica un provvedimento finale pluri-strutturato: la decisione dell’amministrazione demandata a procedere, che sia la Regione o un Comune delegato, richiede il consenso vincolante di un’altra amministrazione, le Soprintendenze, con il rischio che queste ultime non si esprimano nel termine assegnato, oppure che la Regione (o il Comune), pur in presenza del parere favorevole della Soprintendenza, non rilasci il provvedimento.
Una doppia competenza non calibrata in considerazione sia delle caratteristiche degli interventi edilizi (che in molti casi sono di entità minima), sia della stessa organizzazione amministrativa che, in determinate realtà, porta a un numero eccessivo di presentazioni di pratiche, con il rischio di non prestare la dovuta attenzione agli interventi che, invece, necessiterebbero di una maggiore valutazione.
Da qui la necessità, sottolineata dall’Ance, di ulteriori interventi, alcune precisazioni, nonché un maggior coordinamento con le normative collegate alla disciplina paesaggistica, dalla conferenza di servizi alla disciplina dei titoli edilizi e altro ancora.
Nel dettaglio, l'Associazione nazionale dei costruttori edili evidenzia l’opportunità che la delega alla revisione del Dpr 31/2017 sul rilascio dell’autorizzazione semplificata sia ampliata e coordinata con quanto recentemente previsto dal Decreto Proroga Termini 2025, che ha spostato al 27 agosto 2026 il termine per riordinare, ampliare e precisare le categorie di interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata e quelli del tutto esclusi, operando ulteriori semplificazioni procedimentali e documentali.
Con riferimento invece alla delega per rivedere il regime ordinario dell’autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004), essa prevede molti snellimenti, alcuni dei quali di notevole rilevanza, come l’attribuzione dell’autorizzazione paesaggistica semplificata alla competenza esclusiva degli enti locali previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico regionale. Tuttavia, sarebbero opportuni alcuni miglioramenti: ad esempio, il rilascio dell’autorizzazione semplificata da parte degli enti locali previa verifica di conformità con il Piano paesaggistico non tiene conto che molte Regioni sono prive di tale piano; inoltre, il criterio sugli Sportelli Unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche necessita di coordinamento con la disciplina della conferenza di servizi. Sarebbe inoltre utile implementare ulteriori criteri di delega, considerando aspetti importanti quali l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, la rimodulazione dei termini, la previsione esplicita e generale del silenzio-assenso e altri meccanismi per il superamento dell’inerzia, nonché l’eliminazione del “doppio passaggio” per gli interventi edilizi conformi ai piani attuativi già sottoposti a valutazione paesaggistica.
“L’esame sull’autorizzazione paesaggistica sia di procedure estremamente complesse sia di interventi edilizi minori sta sovraccaricando le strutture”, ha concluso Betti. “Quindi ben venga un procedimento come questo, che cerca di dare maggiore equilibrio alla materia e chiarezza ai tempi amministrativi, consentendo una maggiore efficacia nell’azione dei Comuni e, di conseguenza, anche di noi operatori.”
La posizione del CNAPPC
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ritiene condivisibili gli obiettivi di riduzione dei tempi amministrativi, di rafforzamento dell’efficacia dell’azione degli enti locali e di miglioramento della certezza del diritto contenuti nella proposta di revisione del Codice dei Beni culturali.
Ritiene, altresì, che questa revisione, in tema di autorizzazione paesaggistica, debba rientrare in una definizione organica aggiornata delle procedure amministrative e di strumenti quali i Piani Paesaggistici per una valutazione del loro impatto nel bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, in riferimento alle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici, allo scopo di garantire la funzione sociale del paesaggio.
È questa in sintesi la posizione espressa dal CNAPPC nel corso della recente audizione sulla revisione del Codice dei Beni culturali alla quale ha partecipato, davanti alle Commissioni Ambiente e Cultura del Senato, il Consigliere Anna Buzzacchi, responsabile del Dipartimento Patrimonio culturale, ambiente e sostenibilità (in allegato la Memoria).
Per il CNAPPC va sottolineata la criticità della presenza eterogenea dei Piani Paesaggistici approvati dalle Regioni e, pertanto, la difficoltà di attribuzione ai poteri locali del potere di espressione del parere in conformità agli stessi Piani, senza l’espressione di parere preventivo da parte della Soprintendenza.
“Viene da domandarsi - è stato sottolineato - perché il Piano Paesaggistico non venga valorizzato come elemento di orientamento nella pianificazione dei territori in modo che possa crearsi la condizione per introdurre anche lo strumento del silenzio-assenso”.
Altra considerazione riguarda l’introduzione della Direttiva EPBD (Case Green) che rende necessaria l’armonizzazione del quadro normativo vigente per conciliare transizione energetica e paesaggio – ambiente e paesaggio - nozioni che vanno tenute distinte: l’ambiente presuppone un concetto fisico legato a quello di ecosistema mentre il paesaggio ha una dimensione percettiva, etica, relazionale”.
Per quanto riguarda la necessaria semplificazione va rilevato che essa senza strumenti idonei può creare complicazione applicativa. In questo quadro per il CNAPPC deve trovare posto anche la regolamentazione delle funzioni delle Commissioni locali del paesaggio per evitare scelte arbitrarie e meramente soggettive, in assenza di una chiara normativa di riferimento e di indicazioni in grado di definire la loro attività, prevedendone una composizione competente ed un adeguato riconoscimento di compenso.