La Corte dei conti, nella sua ultima relazione semestrale sull’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ha acceso i riflettori sull’efficacia economica del Superbonus 110%, una delle misure più discusse degli ultimi anni. Sebbene l’agevolazione abbia dato risultati positivi in termini di efficientamento energetico e riduzione delle emissioni di CO2, il bilancio costi-benefici si presenta meno entusiasmante, con tempi di ritorno dell’investimento che sollevano più di una preoccupazione.
Efficienza energetica e risultati raggiunti
Nonostante le criticità economiche, dal punto di vista tecnico il Superbonus ha mostrato una capacità significativa di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio. L’obiettivo del Pnrr di efficientare 35,8 milioni di metri quadrati entro la fine del 2025 sembra ampiamente alla portata. I dati del ReGis parlano di 17,58 milioni di metri quadrati già riqualificati grazie ai 60.756 progetti finanziati dal Pnrr, superando il target intermedio di 17 milioni previsto entro il 2023.
Un bilancio economico in chiaroscuro
Il nodo principale, però, resta la sostenibilità economica della misura. Secondo l’analisi della Corte, basata sui dati parziali forniti dall’Enea, il tempo di ritorno dell’investimento si attesta a 35 anni, con il punto di pareggio che si raggiungerebbe solo nel 2057. Una prospettiva problematica, considerata la vita utile limitata di molti materiali e impianti incentivati, come caldaie e pompe di calore, che difficilmente superano i 20-25 anni. Questo porta i magistrati contabili a una conclusione netta: l’analisi costi-benefici del Superbonus sarebbe negativa.
Impatto sul Pil e ritorno fiscale
Anche considerando l’impatto della misura sulla crescita economica e il gettito fiscale, il quadro non migliora significativamente. Tra il 2019 e il 2023, il settore delle costruzioni residenziali ha registrato un incremento del 73%, contribuendo per 3,4 punti percentuali all’aumento complessivo del Pil (+5,4%). Tuttavia, è difficile stabilire quanto di questo risultato sia attribuibile al Superbonus. Secondo i calcoli di Bankitalia, circa il 27% degli interventi sarebbe stato realizzato anche senza l’incentivo. Ciò significa che degli oltre 123 miliardi di euro di investimenti incentivati, solo 82,3 miliardi rappresentano investimenti aggiuntivi.
Il rientro fiscale derivante dall’incremento del Pil, considerando un livello di pressione fiscale del 42%, è stimato in 34,6 miliardi. Di conseguenza, il costo netto della misura scenderebbe a 88,64 miliardi di euro, che attualizzati al 2021 diventano 82,71 miliardi. In questo scenario, il tempo di ritorno dell’investimento si riduce a 24 anni, comunque troppo lungo rispetto alla vita media dei materiali e degli impianti.
Critiche e raccomandazioni della Corte dei conti
La Corte ha accolto positivamente la decisione del Governo Meloni di rimodulare drasticamente il Superbonus, giudicandola necessaria alla luce delle criticità emerse. Inoltre, suggerisce ulteriori interventi per migliorare l’efficacia della misura. Tra le proposte vi è l’adozione di un sistema di detrazioni differenziate, con aliquote più elevate per gli interventi maggiormente efficienti, come il cappotto termico o l’installazione di collettori solari, rispetto a interventi meno incisivi.
Guardando al 2030, il contributo del Superbonus alla riduzione dei consumi energetici nel settore residenziale appare insufficiente per garantire il raggiungimento degli obiettivi del nuovo Piano Nazionale Energia e Clima. La misura, pur avendo catalizzato notevoli risorse e attenzioni, sembra non essere riuscita a imprimere l’accelerazione necessaria per un reale cambio di passo nella transizione energetica.
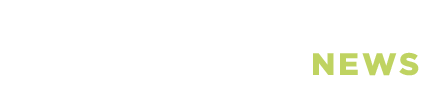




 fonte Shutterstock
fonte Shutterstock

